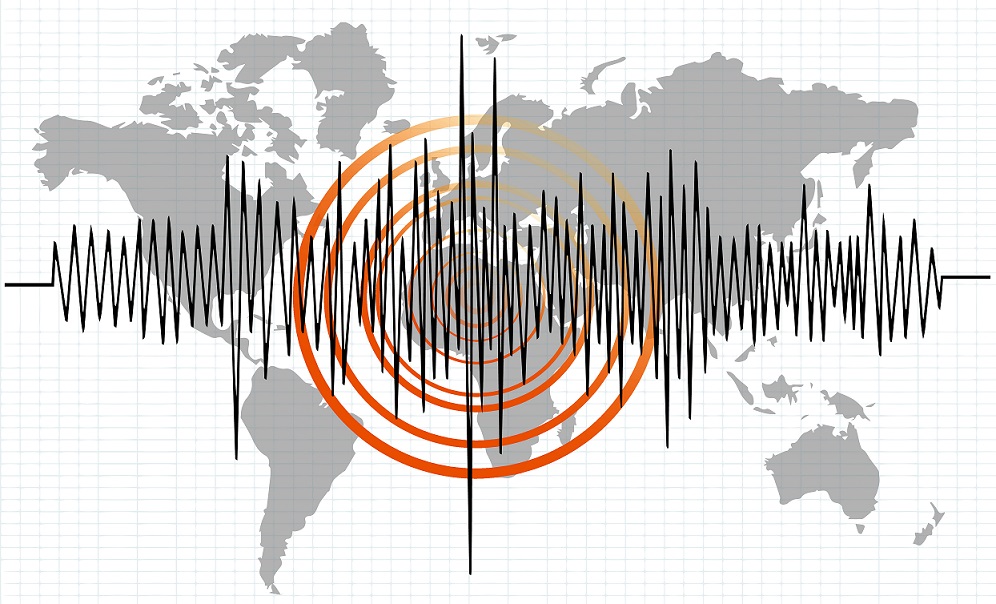Il geofisico Ingv Piscini: “Dal nostro studio sulle variazioni di temperatura delle superfici un primo passo, ma bisogna pensare a un sistema basato su più parametri diversi”
Riusciremo, un giorno, a prevedere i terremoti?
L’obiettivo è ambizioso, la strada è lunga e dunque non si può ancora rispondere affermativamente alla domanda.
Gli esperti, però, continuano a studiare tutto ciò che potrebbe contribuire a sviluppare un modello utile in questa prospettiva.
E si presentano come incoraggianti i primi risultati emersi da uno studio sull’aumento delle temperature della superficie terrestre che si registrerebbe nei giorni precedenti ai sismi, recentemente pubblicato da un gruppo di ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, tra cui il geofisico Alessandro Piscini.

“Bisogna andare cauti, perché siamo in una fase ancora molto preliminare e dunque servirà una serie di studi molto complessi: andranno raccolti molti dati e pensiamo per esempio di realizzare in futuro uno studio che coinvolga non solo l’osservabile nostro, ma anche quanto rilevato da altri. La direzione è questa e la stiamo seguendo. Possiamo però dire che, in questo percorso, siamo riusciti a compiere un primo passo, inserendo un tassello insieme a quelli che stanno provando a costruire altri colleghi”.
- Il vostro studio è partito dai Campi Flegrei: l’innovativo metodo che avete seguito è applicabile anche a sistemi vulcanici diversi da quelli di una caldera come quella campana?
“La notizia dei risultati che abbiamo raggiunto ha avuto particolare risonanza probabilmente proprio perché abbiamo provato ad applicare il metodo, sia pure molto prima degli sviluppi recenti, a una zona che in questo periodo è al centro delle cronache. E sicuramente la topografia piana dei Campi Flegrei ha anche reso più facile l’analisi. Ma stiamo già utilizzando lo stesso approccio anche su coni vulcanici attivi, come Etna e Vulcano”.

- A cosa si può verosimilmente puntare per arrivare a prevedere i terremoti?
“Bisogna pensare a un sistema multi-parametrico, provando a capire la correlazione di ogni osservabile con l’evento sismico e a stabilire l’indipendenza o al contrario l’interdipendenza tra diversi osservabili. L’Osservatorio vesuviano dell’Ingv sta svolgendo un lavoro molto buono, considerando numerosi parametri, per esempio dal punto di vista geochimico, sismico e termico. E la letteratura scientifica concorda con quanto è stato trovato in merito a sollevamento del suolo, emissioni, gas di pressione di sistema. Io vorrei insistere ad analizzare questa serie, per capire se c’è una correlazione e così provare a individuare un possibile criterio di predizione. Ma, ripeto, ci vorrà tempo e al momento non è possibile”.

- In concreto, su cosa avete puntato nello studio appena pubblicato?
“La nostra è stata quella che si definisce “procedura economica”: abbiamo sfruttato dei sensori installati nella Stazione Spaziale Internazionale nel 2018, appurando che ciò ci consente di avere passaggi tutto sommato regolari e soprattutto una risoluzione spaziale abbastanza spinta, di 70 metri per pixel. Per capirci, personalmente da una decina d’anni effettuo studi e analisi statistiche sui precursori sismici, analizzando dati atmosferici-meteorologici realizzati attraverso simulazioni dal Centro europeo che sfruttano un modello con una risoluzione di chilometri”.

- Avete però sempre puntato alla massima precisione statistica, giusto?
“I dati della Iss ci hanno messo a disposizione una serie lunga, tra il 2021 e il 2024, su un’area specifica, consentendoci di tirare fuori i dati delle temperature superficiali da un contesto reale e più spinto. Il dato che abbiamo osservato non è stato tanto quello della temperatura dell’area, quanto il residuo, cioè la differenza tra l’emissione della solfatara e un background statisticamente libero dalle fluttuazioni stagionali. Nell’approccio statistico, abbiamo cercato il più possibile di eliminare i problemi che possono aprire contestazioni scientifiche, provando a ridurre al minimo gli errori di distribuzione statistica per approssimare il dato al meglio. E, con il secondo dei due approcci, oltre a valutare l’oscillazione del segnale abbiamo guardato anche all’evoluzione del sistema, ottenendo dati utili sia per i geofisici che per i vulcanologi”.
Alberto Minazzi