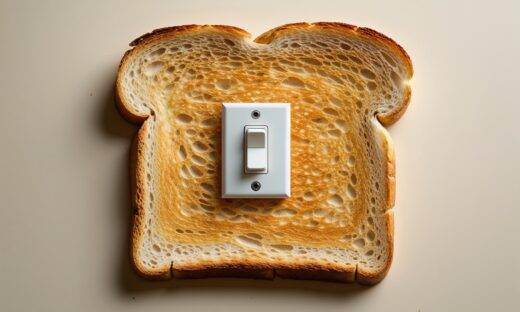Dopo anni di inquinamento e malattie, a pochi giorni dalla sentenza della Corte dei diritti dell’uomo, il governo italiano nomina un commissario per risanare l’area. Entro 2 mesi la sua relazione con il piano per il ripristino ambientale
Come confermarono le dichiarazioni del pentito Carmine Schiavone, ex amministratore e consigliere del Clan dei Casalesi, tra gli obiettivi della camorra c’era quello di trasformare la Campania in una discarica a cielo aperto, soprattutto di materiali tossici. Fin dagli anni ’80 dello scorso secolo, del resto, la criminalità organizzata campana si era iniziata a interessare dello smaltimento dei rifiuti, in quanto attività particolarmente redditizia.
Si creò così nel tempo quella che il rapporto Ecomafie di Legambiente nel 2003 definì per la prima volta “Terra dei fuochi” riferendosi all’area maggiormente interessata del fenomeno delle discariche abusive: 1076 km quadrati, tra la città metropolitana di Napoli e la provincia di Caserta, in cui risiedono circa 2,5 milioni di abitanti in 57 comuni.
Un’etichetta poi ripresa da Roberto Saviano, che diede proprio questo titolo all’ultimo capitolo del suo libro “Gomorra”.
Un fenomeno che l’Italia ha cominciato ad affrontare con decisione solo a partire dal 2013, quando iniziò in Parlamento la discussione su 9 mozioni relative alla bonifica di alcuni siti inquinati di interesse nazionale. I provvedimenti che ne seguirono sono stati però troppo tardivi e, in ogni caso, comunque insufficienti, secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu), che ha condannato l’Italia lo scorso 31 gennaio per la gestione. Ma qualcosa potrebbe adesso cambiare.

Il commissario unico per la Terra dei fuochi
Proprio la garanzia dell’attuazione della sentenza, come ha sottolineato la premier Giorgia Meloni dando l’annuncio, è una delle ragioni che ha portato il Consiglio dei Ministri, nell’ultima riunione a inserire nuove norme, a partire dall’istituzione di un commissario unico nazionale per il coordinamento della bonifica dell’area, contrastando il fenomeno dell’inquinamento ambientale derivante dall’abbandono dei rifiuti attraverso un intervento programmatico adeguato.
E’ stato dunque nominato nel ruolo il generale Giuseppe Vadalà, dal 2017 commissario straordinario per la bonifica delle discariche abusive, che si sta occupando dal 2023 anche della messa in sicurezza della discarica romana di Malagrotta, chiusa dal 2013. Per svolgere il suo ruolo di coordinamento avrà poteri straordinari legati alle attività indicate dalla sentenza della Cedu e potrà contare su una struttura di supporto composta da 25 unità.
Nello specifico, il commissario potrà effettuare una ricognizione degli interventi di indagine ambientale, caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica effettuati e programmati, così come delle iniziative volte a garantire la salubrità dei prodotti agroalimentari, il monitoraggio ambientale e sanitario delle popolazioni nell’area interessata, ma anche verificare le risorse stanziate e disponibili per le bonifiche e individuare e perimetrare i siti oggetto di contaminazione.

Una relazione verso le bonifiche
Il primo atto che dovrà produrre Vadalà è una relazione sulla ricognizione degli interventi, da realizzate entro 60 giorni per poi trasmetterla alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai Ministeri dell’Ambiente e della Salute, alla Regione Campania e agli altri soggetti competenti a vario titolo.
La relazione dovrà fare il punto sullo stato dell’arte e indicare le azioni che il commissario intende intraprendere per arrivare all’obiettivo della bonifica e del ripristino ambientale.
Attraverso la nomina del commissario, ha spiegato ancora Meloni, si mira a superare la situazione di stallo che finora ha impedito il completamento in tempi accettabili degli interventi di bonifica. L’attuazione di questi interventi dipendeva infatti da diversi livelli di governo, sia nazionale che territoriale, mentre ora si riporta interamente in capo a un soggetto unico, che potrà dunque rispondere alla richiesta di elaborare una strategia articolata avanzata dalla Cedu.
La sentenza di condanna per l’Italia
Accogliendo un ricorso presentato da 5 associazioni e 41 persone, che in gran parte hanno sviluppato un tumore o comunque sono parenti di persone decedute a causa del cancro, la Corte dei diritti dell’uomo aveva condannato 3 settimane fa l’Italia per non aver adottato misure adeguate per fronteggiare l’inquinamento dell’area, nonostante l’inizio delle violazioni risalga nel tempo e queste siano state oggetto di numerosi contenziosi.
Non affrontando la questione in modo diligente, tempestivo ed efficace, ha decretato la Corte, lo Stato italiano avrebbe violato lo stesso diritto alla vita di chi abita nella Terra dei fuochi. Il rischio che corrono, oltre che “imminente”, è stato definito dalla Cedu come “sufficientemente serio, reale e accertabile”. Tra le accuse mosse al Governo italiano c’è inoltre quella di essere stato a conoscenza del problema da molti anni, configurandosi quindi una responsabilità diretta.

La sentenza, vincolante anche se non definitiva (è possibile presentare appello entro 3 mesi alla Grand Chamber), sottolinea anche che “non è possibile avere un’idea generale di quali siano le aree ancora da decontaminare”, ordina di istituire un meccanismo di monitoraggio indipendente e di attivare entro 2 anni (durante i quali saranno messi in pausa gli altri 36 ricorsi già presentati alla Corte) una piattaforma di informazione pubblica.
La Terra dei fuochi
Il fenomeno dello smaltimento illecito dei rifiuti, in gran parte “speciali” (che richiedono un trattamento particolare) nel tempo si è allargato a ulteriori zone della Campania, raggiungendo anche la provincia di Salerno.
Ma il “cuore” resta il quadrilatero compreso tra il litorale domitio, l’agro aversano-atellano, l’agro acerrano-nolano e vesuviano e la città di Napoli. Qui è attualmente attivo un servizio di pattugliamento e rilevamento dei roghi tossici garantito da operai specializzati.
Per smaltire i rifiuti e liberare i siti, la camorra ricorre infatti in molti casi all’incenerimento a cielo aperto, con roghi (di qui il nome) che diffondono nell’atmosfera diossina e altri gas inquinanti.
I primi sospetti di un’attività illecita risalgono agli anni Novanta, con l’indagine dell’ispettore della Polizia di Stato Roberto Mancini (deceduto nel 2014 per una leucemia legata all’esposizione alle sostanze) i cui risultati furono consegnati alla Direzione distrettuale antimafia nel 1996.
La correlazione tra esposizione ambientale e tumori non è di semplice definizione, ma esistono numerosi studi che l’hanno confermata sulla base dell’incidenza più elevata rispetto alle medie nazionali dei casi di tumore tra la popolazione locale e la presenza di inquinanti e cancerogeni nel fisico di chi è malato di cancro.
Nel 2008, la Terra dei fuochi fu al centro delle cronache anche per la presenza di diossina nel latte delle bufale casertane.
Alberto Minazzi