La moderna evoluzione dell’identità personale al di là della realtà fisica apre a numerose questioni legali per i vuoti di tutela in materia di successioni
Cos’è una “persona”?
Alla domanda, fin dagli albori della storia del pensiero, ha provato a dare una risposta innanzitutto la filosofia. Un tema che, dopo le riflessioni degli antichi Greci e Romani è letteralmente esploso nell’era moderna a partire dal 1600, con Hobbes e Pascal prima e altri grandi filosofi, da Hume a Kant, poi.
Ma il quesito antropologico si è via via esteso anche ad altri settori del sapere. E l’evoluzione della tecnologia ha dato vita a nuove questioni di non facile soluzione. In campo giuridico, così, la nuova dimensione dell’identità personale, che trascende sempre più la fisicità, apre al dibattito per esempio in materia successoria.
Perché il nostro “essere” parallelo, a partire dai tanti profili a noi riconducibili che si trovano in rete o sui social network, può prolungare ben oltre la naturale fine della vita la permanenza dell’identità virtuale. E conseguenze ed effetti legati all’“eredità digitale” sono ancora tutt’altro che perfettamente definite nella loro regolamentazione.
I vuoti di tutela legati all’evoluzione digitale dell’identità
Uno studio del Consiglio Nazionale del Notariato, firmato da Diego Apostolo, si sofferma proprio su questi temi, sottolineando come la rivoluzione digitale abbia “provocato effetti significativi, anche dal punto di vista successorio, che impongono capacità di adattamento delle categorie tradizionali, e delle teorie classiche, alla luce dell’evoluzione (digitale) dello stesso concetto di “identità”, di “morte” e di “eredità”.
“Allo stato attuale – prosegue l’abstract dello studio – viene riconosciuta una protezione normativa limitata, lasciando alla giurisprudenza il compito di colmare alcuni vuoti di tutela e al testatore il compito di regolamentare la vicenda successoria avente ad oggetto le “entità digitali” con gli strumenti giuridici a disposizione, per come consegnati dall’attuale ordinamento”.
Giuridicamente, si sta passando sempre più da una concezione “fissa” dell’identità personale a una “dinamica”, che la intende come “processo continuo di costruzione e di identificazione con uno o più modelli rinvenibili in un dato ambiente sociale”. Sovrapponendo mondo reale e virtuale, si è dunque progressivamente generata una sorta di “identità parallela”, quella digitale, rispetto a quella tradizionalmente intesa, ormai comunemente accolta in rete.

L’identità digitale e i diritti a essa legati
Quando si presentano vuoti normativi, come quello di cui stiamo parlando, in attesa di un intervento del legislatore è la giurisprudenza che è chiamata a colmarli. Così, per esempio, l’identità digitale ha aperto a questioni come quelle relative al tema del diritto all’oblio in internet, per la tutela della reputazione del titolare, e, più in generale, al diritto alla continua e corretta proiezione della propria identità personale all’interno della rete.
Un’identità, quella virtuale, che, non va dimenticato, nasce su base volontaria e che è stata riconosciuta dagli operatori del diritto come “ubiqua, perenne, manipolabile e non unitaria”. “Paradossalmente – sottolinea lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato – e per sua stessa natura, l’identità digitale si risolve in una rappresentazione virtuale tendenzialmente fissa e ad alto rischio di obsolescenza di informazioni relative ad un determinato soggetto”.
La personalità dell’utente, cioè, una volta immessa in internet viene codificata e memorizzata su supporti informatici, “trovando una forma di “storicizzazione binaria” e, quindi, di oggettivizzazione, del tutto sconosciuta (o, comunque, molto poco conosciuta e indagata) nel mondo reale tale da renderle suscettibili di valutazione anche in termini economici”.
La “morte digitale” e le sue conseguenze
Finché il soggetto è in vita, può provvedere direttamente alla tutela della propria identità digitale. Emerge però una serie di problemi dopo la sua morte. Attraverso le norme sulla successione, l’ordinamento prevede che, nelle situazioni soggettive giuridicamente rilevanti facenti capo al defunto, subentri un altro soggetto, sia esso erede o semplice legatario. Ma la regola generale è che si possano trasmettere i soli diritti patrimoniali, ma non quelli “personalissimi”.
E non solo. Rispetto alla “morte biologica”, la “morte digitale” è molto più difficile da inquadrare. Per di più, con il decesso (fisico) si verifica una sorta di dissociazione tra persona naturale e persona digitale, con il “corpo elettronico” che continua a sopravvivere, potenzialmente in modo immortale, attraverso i dati e le informazioni presenti in rete.
In questi casi, il nostro ordinamento prevede, come regola generale, la sopravvivenza dei diritti dell’interessato e la possibilità del loro esercizio, dopo la morte, da parte di determinati soggetti legittimati all’esercizio dei diritti stessi. E la disposizione attorno cui attualmente ruota il sistema di tutela post mortem e dell’accesso ai dati personali del defunto è contenuta nel decreto legislativo 101 del 2018, che definisce i soggetti autorizzati all’esercizio dei diritti relativi.
Eredità digitale: meglio fare testamento
Questa facoltà di esercitare i diritti di accesso, di rettifica e cancellazione, di limitazione di trattamento, di opposizione e di portabilità dei dati spetta, ferma restando la possibilità di un espresso divieto da parte del defunto, a “chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione”. Il legislatore, però, non si esprime sulla questione relativa alla trasmissione effettiva dei diritti agli eredi.
Si entra dunque nel campo dell’“eredità digitale”, premettendo che, nell’attuale sistema, non sono previsti specifici strumenti giuridici per la trasmissione mortis causa delle entità digitali. Al momento, dunque, conclude anche lo studio, lo strumento più adatto allo scopo appare ancora il testamento, attraverso il quale si possono nominare espressamente i propri “eredi digitali” ed evitare problemi legali o addirittura la perdita di parte dell’identità virtuale del defunto.
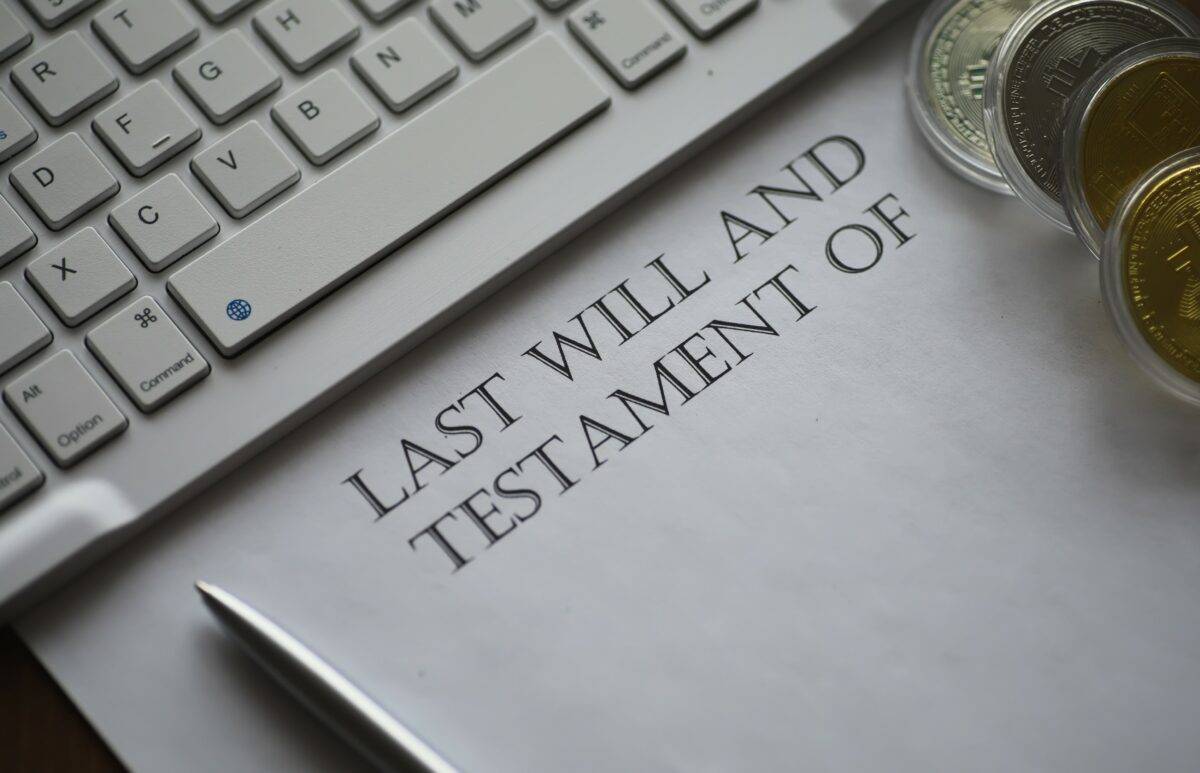
Il patrimonio digitale soggetto a eredità
Le lacune legislative riguardano anche la definizione tecnica di “patrimonio digitale”, anche ai fini della previsione di una successione testamentaria. Tra i beni e i dati che una persona possiede o gestisce online possono dunque rientrare i profili social, gli account di posta elettronica, streaming o e-commerce, i documeni salvati in cloud, i contenuti multimediali acquistati online, le criptovalute, ma anche i commenti, le recensioni o i post.
La definizione di “beni digitali” ricomprende dunque, in generale, i beni mobili, online e offline, rappresentati in formato binario, cioè nel linguaggio utilizzato dai computer. Insieme a quelli “patrimoniali”, cioè suscettibili di valutazione economica, vi rientrano anche quelli “non patrimoniali”, che rispondono a interessi individuali, morali, affettivi e familiari, e quelli “ibridi”, non definibili cioè a priori all’interno di una specifica categoria.
Relativamente ad account e credenziali, lo studio suggerisce una possibile successione solo nella posizione contrattuale, di norma però “non consentita dal contratto concluso con il fornitore di servizi informatici”. Le criptovalute sono invece qualificate come beni digitali mobili e i conti online “seguono le ordinarie regole della successione”.
Non formano invece oggetto di successione i contenuti concessi in licenza e gli account di firma elettronica e digitale.
Come agire per facilitare la trasmissione dell’eredità digitale
Tra i suggerimenti da seguire per la trasmissione dell’eredità digitale, il primo è la creazione di un inventario digitale, in cui inserire tutti gli account, i dati e i beni digitali in nostro possesso, indicando soprattutto il nome della piattaforma o del servizio, le credenziali di accesso e il valore economico o personale che vi si attribuisce. Va poi designato un erede digitale, cioè la persona alla quale intendiamo affidare la gestione del nostro patrimonio digitale dopo la nostra morte.
Attraverso il testamento digitale è quindi possibile dare indicazioni all’erede, per esempio sugli account da tenere attivi o da chiudere, le istruzioni per il trasferimento delle criptovalute e degli altri beni digitali, ma anche la volontà o meno di conservare le tracce che abbiamo lasciato online. Il testamento andrà redatto nelle forme legali generali previste dal nostro ordinamento, anche se i gestori delle principali piattaforme mettono a disposizione alcuni strumenti.
Fin dal 2013, Google consente per esempio di configurare sui suoi vari servizi (da Gmail a Youtube) un “Inactive account manager”, che permette la gestione e la supervisione futura degli account quando l’indirizzo diventi automaticamente inattivo. Da fine 2021, invece, Apple ha inserito nel sistema operativo dell’iPhone l’opzione attraverso cui si possono scegliere gli eredi a cui verranno forniti i dati d’accesso dopo la morte del titolare.
Alberto Minazzi




