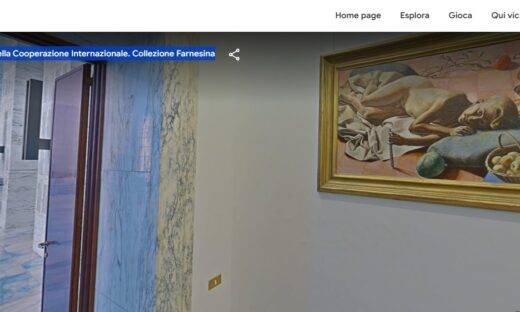Un libro raccoglie le locandine di Renato Casaro, l’artista trevigiano amato dai grandi registi
Quella volta Sergio Leone gli chiese di sintetizzare in un’immagine “C’era una volta in America”, il film complesso e monumentale che aveva impiegato un anno a girare. Non aveva idee, si affidò alla creatività del suo illustratore. Per il grande regista, Renato Casaro aveva già lavorato agli inizi degli anni ’60 realizzando le celebri locandine della trilogia spaghetti-western iniziata con “Per un pugno di dollari”, che girarono tutto il mondo con l’effigie di Clint Eastwood, un emerito sconosciuto che divenne subito celebre a Hollywood.
Per il film del 1984, Casaro disegnò invece quattro teste su fondo nero. Una locandina che ha fatto la storia del cinema, e che è ora la copertina del libro “Renato Casaro. The art of movie painting” (Edizione Moderna), che raccoglie tutti i lavori fatti dall’inizio della carriera dall’artista trevigiano. Già, perché è sorprendente, ma tranne gli addetti ai lavori pochi sanno che a disegnare le immagini chiave che hanno reso immediatamente riconoscibili e celebri film che hanno fatto la storia del cinema, c’è il trevigiano Renato Casaro, classe 1935. Solo alcuni titoli: “Il tè nel deserto”, “Balla coi lupi”, “L’ultimo imperatore”, “Amadeus”, “Conan il barbaro”, “Nikita”, “Rambo”, “Il postino suona sempre due volte”, “Cotton Club”, “Il piccolo Buddha”, “Il nome della rosa”… Una lista infinita, impressionante, da lasciare a bocca aperta.

Ma com’è, gli chiediamo, che un trevigiano finisce a Hollywood e diventa il disegnatore più conteso del mondo della celluloide? Passione, voglia di riuscire, tante fortuite coincidenze che si sono succedute. Quand’ero ragazzo amavo infilarmi al cinema Garibaldi della mia città e rivedermi lo stesso film per ore. Mi piaceva molto disegnare: prendevo qualche locandina, la portavo a casa, la studiavo, la copiavo. Qualcuna mi riusciva bene, così iniziai a portarle al direttore del cinema. Che apprezzò molto, tanto da farmi disegnare le sagome, quei grandi pannelli che reclamizzavano i film vicino alla cassa. Poi li fotografava e li mandava a Roma, alla Lux, alla Medusa, le case che distribuivano i film, e mi rendeva orgoglioso. Volevo andare a lavorare nella capitale.
Anni ’50, Roma era la Mecca del cinema europeo… Il direttore del cinema Garibaldi credette in me. Mi fece una lettera di presentazione. Partii per Roma, un viaggio importante per quel periodo. Avevo 19 anni, conscio di vivere un’avventura straordinaria. Grazie ad alcuni lavori fatti alla Lux, parlai con lo Studio Favalli, che mi commissionò la prima locandina per il film “Totò, destinazione Piovarolo”. Piacque molto e mi assunse, così mi trasferii a Roma da una zia. Per un anno e mezzo stetti lì, imparai molto. Poi mi misi in proprio.
C’era tanto lavoro, allora? Mi stavo inserendo, ma era difficile entrare nella cerchia giusta. Disegnavo i fumetti di Capitan Walter. Ma capitò un’occasione: la casa Medusa stava fallendo e doveva ancora distribuire dei film, ma non poteva permettersi disegnatori di grido. Assegnò a me i lavori, tra i quali “Due occhi azzurri” con Marianne Koch. Il disegno riprendeva in più espressioni il solo sguardo dell’attrice. Fu una novità che mi permise di farmi notare. Ed ebbi un’altra fortuna: incontrai il produttore Dino De Laurentiis.
Fu il punto di svolta? Sì, perché mi commissionò il disegno per “La Bibbia” di John Huston. Doveva essere il cartellone, grande sei metri per tre, da posare sul Sunset Boulevard di Hollywood. Fu una grandissima emozione. Questo mi permise di conoscere Sergio Leone, che mi commissionò la trilogia western. Da allora fu un crescendo. Viaggiavo di continuo, andavo sui set cinematografici. Osservavo girare le scene, fotografavo e poi buttavo giù degli schizzi, idee che sceglievo con il regista.
Rosi, Bertolucci, Ford Coppola, Lelouch, Fassbinder, Costner: sono solo alcuni dei registi che le hanno affidato l’immagine-emblema del loro film. Quella di “Balla coi Lupi” fu una bella soddisfazione. Quando incontrai Kevin Costner alla prima del film, si passò due dita sulla guancia, a ricordare i segni colorati indiani che avevo disegnato. Tutto durò fino agli anni ’90.
Perché? Cosa successe poi? L’avvento del digitale, che cambiò il modo di illustrare nel cinema. I grafici potevano ora realizzare in poco tempo e a basso costo le copertine. Cambiai anch’io. Mi dedicai al filone “painted movies”: dipinti di opere famose animate dalle figure degli attori di Hollywood. Non faccio più le illustrazioni per il cinema anche se, confesso, una sfida contro qualche collega del computer la farei volentieri.